
Alla fine del mio «Di Pietro, la storia vera» che esce martedì c’è un fuori-capitolo che racchiude alcune peripezie personali che ho sempre omesso di raccontare. Non farlo neppure ‘stavolta sarebbe stata reticenza.
Avevo ventiquattro anni e volevo fare il giornalista. Nel gennaio 1991 vantavo già tre o quattro querele e fu allora che incontrai Antonio Di Pietro per la prima volta. Avevo cominciato presto, e dal giornaletto in cui spadroneggiavo, a Monza, approdai a delle collaborazioni con «l’Unità» e con «la Repubblica». Tuttavia le querele giungevano scientificamente solo al giornaletto che mi dava da vivere e che perciò dovetti lasciare.
Di Pietro lo conobbi appunto per una querela: era in toga e me l’indicarono; gli rivolsi un saluto formale che lui non ricambiò. Non gl’importava nulla di quella causa, lo si capiva. Sembrava mestamente annoiato dalle sciocchezze e dalle querele di me giornalistucolo, e quella sua burocratica indolenza non me la sarei più schiodata dalla mente. La querela non ebbe seguito.
Finito il militare, i miei contatti con «l’Unità» e con «la Repubblica» erano saltati. Mi ero sposato l’anno prima, a ventitré anni, ed ero disoccupato: l’unico contatto che riuscii a procurarmi fu con la redazione milanese dell’«Avanti!», dove per un paio d’anni avrei lavorato da abusivo. A me importava solo di fare il giornalista.
Mi diedi da fare. Di Pietro lo rividi nel dicembre 1991 quando mi mandarono a intervistarlo con la testuale premessa che era «amico nostro». L’incontrai di nuovo seguendo Mani pulite: l’«Avanti!» era ritenuto il giornale dei ladri e lo chiamavano «la gazzetta degli avvocati», e tra una diffidenza e l’altra i nervi di una mia collega avevano cominciato a cedere; avevano mandato avanti me perché secondo il mio caporedattore ero un «cane sciolto».
Ma un cronista dell’«Avanti!», al tempo, aveva poche alternative tra l’essere considerato un cane sciolto o l’essere considerato un cane. Ricordo quando entrai nella sala stampa del palazzo di giustizia e tutti uscirono, come capitò anche a un cronista del «Secolo d’Italia». Ricordo quando davanti a una clinica privata, dove un famoso finanziere era agli arresti ospedalieri, il gruppetto dei cronisti cambiava marciapiede a seconda della mia posizione. Quando mi capitò di pubblicare dei verbali d’interrogatorio che guastarono i piani di chi scriveva in pool, poi, un collega mi disse a brutto muso che secondo lui i miei verbali erano falsi. Un altro cronista mise in relazione la fuga notturna di un dirigente socialista con una mia possibile spiata. Lo scrisse pure.
In tutto questo la situazione si era fatta ancora più complicata perché la sede romana dell’«Avanti!» vedeva nella redazione milanese un avamposto craxiano – ciò che era – e man mano che decresceva il potere di Craxi cresceva anche il tentativo di isolarci e di toglierci peso. Io formalmente neppure esistevo: non avrei potuto neanche stare in redazione; il direttore di allora, su cui non esprimo un’opinione perché non ho l’immunità parlamentare, si chiamava Roberto Villetti e ogni tanto telefonava da Roma per sincerarsi che io fossi rimasto a casa o scrivessi comunque da fuori, quando invece in redazione praticamente ci dormivo. A un certo punto, in un periodo in cui peraltro non arrivava più una lira perché le tangenti erano finite – questo l’avrei appreso poi – Villetti prese a togliermi anche la firma dagli articoli: ma neppure sempre, a giorni alterni, quando capitava. Pensai di aggirare l’ostacolo ricorrendo alla doppia firma col mio caporedattore milanese, Stefano Carluccio, un amico: ma a un certo punto il direttore risolse togliendo solo la mia firma e lasciando quella di Carluccio sotto articoli che però avevo scritto io.
Nell’insieme: lavoravo da abusivo per il giornale dei ladri, ero disprezzato dai colleghi e da chiunque in quel periodo sapesse dove scrivevo, completamente gratis, in teoria non potevo neppure entrare in redazione e sotto i miei articoli c’era la firma di un altro.
Però c’era la salute.
Continuai a seguire Di Pietro e Mani pulite anche quando l’atmosfera si fece ancora più elettrica e quando due persone che conoscevo, inquisite, si suicidarono. Scrivere sull’«Avanti!» certo mi forzava a guardare le cose da un punto di vista speculare, ma probabilmente c’entrava anche il mio carattere e un’età in cui avevo davvero poco da perdere. In ogni caso il clima che ribolliva nel paese non mi piaceva. Mi venne naturale raccogliere del materiale su cui lavorare: di giorno, quindi, seguivo la cronaca, e la sera ci ragionavo, approfondivo, scrivevo, ne discutevo sino a tarda notte.
Continuai a occuparmi di Di Pietro anche quando l’«Avanti!» chiuse i battenti e rimasi a spasso. Era la fine del 1992. Fu un brutto colpo, soprattutto perché ormai ero catturato dagli avvenimenti. La redazione era chiusa ma spesso ci dormivo dentro perché a casa c’era qualche problema. Presi a indagare, feci domande in giro, raccolsi ritagli di giornale. Un paese intero invocava manette e io intanto fingevo di fare il giornalista come di consueto: assumevo informazioni, le ordinavo, le assemblavo, ne parlavo: solo che, il giorno dopo, non usciva nessun mio articolo. Mi limitavo a ingrassare e limare un mio libro impossibile, una sorta di rivisitazione della carriera di Di Pietro e della sua inchiesta devastante. Non avevo nient’altro da fare, né di nient’altro m’importava.
Era il periodo dei governi che non riuscivano a governare, l’anno delle bombe a Milano e a Roma, delle speculazioni internazionali: l’atmosfera da torbido complotto era illuminata solo dalla mirabolante traiettoria di Antonio Di Pietro. Un sondaggio, tra «abbastanza», «molta» e «moltissima», gli attribuiva il 90 per cento della fiducia degli italiani. Neppure certi suicidi eccellenti avevano scosso l’opinione pubblica: il 60 per cento degli italiani riteneva che l’uso della carcerazione preventiva andasse bene così. Neppure quel clima da carboneria e la mia vocazione di bastiancontrario mi divertivano più: ero pur sempre un ragazzo di ventisei anni che voleva fare il giornalista. Cercai di defilarmi.
Scrivevo. Il libro era ormai denso e particolareggiato sino alla paranoia, quasi quattrocento pagine che ingenuamente e nelle maniere più improbabili tentai di proporre a qualche casa editrice. Non interessò a nessuno perché ero un perfetto sconosciuto, ma nondimeno perché era il periodo che era. Sulla copertina di «tv Sorrisi e Canzoni » l’icona del magistrato più amato dagli italiani troneggiava su un titolo cubitale: Di Pietro facci sognare.
Conobbi Bettino Craxi semplicemente telefonandogli: fu poco prima che quasi lo linciassero all’Hotel Raphaël, all’inizio del 1993. Non dirò nulla di lui. Conobbi altre persone tra le più care, in quel periodo: uomini e ragazzi che difendevano storie che non erano le loro, e che dicevano follie che un giorno sarebbero state ovvie. L’effervescenza di Mani pulite mi disvelò codardie raggelanti e dignità insospettabili.
Il mondo delle persone normali, a poco a poco, mi perse. Sfumarono amicizie e affetti, il matrimonio era ormai consunto, mio padre intanto leggeva il forcaiolo «Indipendente» di Vittorio Feltri. Poi, un giorno di aprile, mi telefonò un personaggio di una fantomatica casa editrice straniera, uno che diceva di aver saputo del mio dattiloscritto da qualche collega di Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano. Si disse interessato. Ci vedemmo due volte in un bar del centro e nel secondo incontro mi mostrò anche un libro pubblicato da questa casa editrice straniera, la Marshall di Dublino. Nel trattenere una copia del mio lavoro mi disse che uno scritto come il mio in Italia non sarebbe mai stato pubblicato, e con mio sbigottimento mi diede una busta che – verificai poi – conteneva 4 milioni in contanti. Gli lasciai anche due mie foto. Una, lo feci per scherzare, mi ritraeva che avevo circa un anno.
A metà luglio il settimanale «Il Sabato» pubblicò un dossier che conteneva tutta una serie di notizie imbarazzanti per Antonio Di Pietro. Erano cose che perlopiù conoscevo e che nel mio libro fantasma avevo sviluppato in parte meglio e in parte peggio. Furono sbrigativamente bollate come «calunnie» come capitava a ogni minimo rilievo mosso contro Di Pietro, ma fu un altro fatto a colpirmi. Mi suonavano stranamente familiari, di quel dossier, almeno un paio di passaggi. Ebbi l’impressione che l’estensore avesse quantomeno consultato il mio libro fantasma, ma fu solo un primo campanello d’allarme. Presto un altro episodio l’avrebbe terribilmente superato.
Il mio ex caporedattore, Stefano Carluccio, mi convinse a fare causa all’«Avanti!» così da ottenere almeno il praticantato d’ufficio, un riconoscimento legale che mi avrebbe permesso di fare l’esame da giornalista professionista. All’Ordine della Lombardia c’era Franco Abruzzo, ritenuto vicino a quel che rimaneva del Psi. La mia causa fu accolta.A Roma feci l’esame scritto e scelsi un tema sul cosiddetto «nuovismo» maturato dopo Mani pulite, anche se l’enfasi della titolazione avrebbe potuto indurmi a migliori consigli. Fui soddisfatto del mio lavoro, ma tempo dopo appresi che mi avevano bocciato. Diedi di nuovo l’esame scritto e scelsi l’analisi di un decreto legge sulla giustizia, il Decreto Gargani. Presi il voto più alto di tutta la sessione.
Preparai l’orale e intanto non combinavo granché. Nel dicembre 1992 avevo conosciuto l’ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri, ex amicone di Antonio Di Pietro, e mi aveva già confidato qualche notevole aneddoto su Tonino, Ninì come lo chiamava lui. Passavo a trovarlo nella ridicola speranza che potesse aiutarmi a trovare lavoro e mi dava udienza anche perché era avvolto da una solitudine impressionante. Un giorno mi mostrò un faldone pieno di appunti infarciti di correzioni illeggibili, voleva una valutazione. La forma faceva abbastanza schifo e glielo dissi, ma gli proposi di fare un libro intervista purché corredato di domande e risposte vere. Pillitteri aveva lottizzato e piazzato giornalisti ai più alti livelli, ora aveva me. Ci mise un po’ ad accettare. A lavoro finito, l’ex sindaco mi favorì due appuntamenti con due editori, ma andò male. Nel febbraio 1994 tentai di mia iniziativa con la romana Newton Compton e sorpresa: accettarono. Mi posero dei tempi di consegna strettissimi così da uscire entro le elezioni del 27 marzo. Ero sbalordito.
L’esame orale da giornalista fu sempre in febbraio. Si doveva discutere una tesina scelta dal candidato e rispondere a un po’ di domande. I commissari sbirciarono il voto dello scritto e si compiacquero. Ma poi, di fronte a una commissione composta da magistrati e giornalisti, cominciai a discutere la tesina «Commistioni tra magistrati e giornalisti nell’inchiesta Mani pulite» perché ero fatto così.
Anche un po’ scemo, a riguardarmi oggi, ma ero uno che non mollava mai. Gli altri aspiranti professionisti sgranarono gli occhi di fronte all’harakiri e l’esame non fu piacevole, durò almeno il doppio del consueto e anche la camera di consiglio si protrasse per un’ora secca. Fui promosso col minimo dei voti, grazie, appresi, a un commissario che poi venne a cercarmi.
Ero finalmente un disoccupato professionista e pensai che l’importante fosse non fermarsi. Cominciai a girare da un avvocato all’altro per raccogliere varie storie di malagiustizia, mia vecchia passione di quando sedicenne militavo nei Radicali. Cercai di condensare queste storie in un altro volume in cerca di fortuna. Ogni tanto ripensavo all’improbabilità di quell’editore straniero, tutte le stranezze, i contanti senza ricevuta, neppure un numero telefonico o un indirizzo dove rintracciarlo. Era sparito e pensai che potesse essere normale in un periodo in cui nulla lo era.
Un vecchio amico di mio padre lavorava alla neonata «Voce» di Montanelli, e provai lì. Erano in overbooking, ma il tizio mi procurò un appuntamento con Maurizio Belpietro, vicedirettore del «Giornale ». Quest’ultimo mi accompagnò dal capo della cronaca di Milano, Daniele Vimercati, e gli propose di mettermi alla prova. Ma non mi chiamò mai. Era un ottimo giornalista, era vicino alle posizioni di Bossi e io ero uno che aveva lavorato all’«Avanti!» da abusivo.
Un mattino mi segnalarono uno dei tanti anonimi su Mani pulite che circolavano per le redazioni. C’era una copertina grigia col titolo Gli omissis di Mani pulite e risultava edito da una certa «Marshall Ltd-Irlanda», firmato da Anonimo giornalista. Centonovantadue pagine fitte. Era il mio libro, Anonimo giornalista ero io. Sulla retrocopertina, piccolina, c’era anche la mia foto di quando avevo un anno.
Rimasi di sale. Da una parte la rabbia per quell’incredibile lavoro perduto nell’oceano degli anonimi, dall’altra un timore irrazionale di venire scoperto per aver fatto qualcosa che in realtà non volevo neppure nascondere. Fu difficile non parlarne con nessuno per mesi, per anni. Tanto più quando il settimanale «Panorama», poco tempo dopo, in un trafiletto, fece cenno al volume e titolò Veleni contro Mani pulite. Mi raccontarono che alcuni colleghi della giudiziaria si divertirono con la caccia all’autore e seppi che non sospettarono di me perché non mi ritenevano all’altezza.
Il libro intervista con Pillitteri, Io li conoscevo bene, uscì a marzo inoltrato. «Panorama» ci dedicò un’intera pagina e altri articoli uscirono sulla «Stampa» e sul «Messaggero». Spesso neppure mi nominavano, ma fui contento anche se dell’argomento principe del libro, Antonio Di Pietro e certi suoi legami imbarazzanti, preferirono non parlare.
Già lavoravo ad altro: la raccolta delle storie di malagiustizia mi appassionava. In luglio, nei giorni del disgraziato Decreto Biondi, il mio amico Luca Josi mi propose di presentarle sotto forma di libro in via di pubblicazione, anche se propriamente non c’era il libro e non c’era l’editore; diceva che si poteva contrapporlo a quanti, a fronte delle lagnanze garantiste, invocavano ogni volta esempi e casi concreti.
Nella saletta di un hotel romano, non certo grazie a me, intervennero Vittorio Sgarbi, l’avvocato Nicolò Amato e il professor Paolo Ungari. Uscì un trafiletto sul «Giornale» e uno sul «Corriere della Sera». Fu un risultato, dati i tempi.
Qualche giorno dopo si fece vivo tal Roberto Maggi, già editore di Sgarbi con la sua Larus di Bergamo. Aveva letto il trafiletto sul «Corriere ». Disse che il libro gli interessava molto ma tutto venne rimandato a settembre. Gli credetti. Passai l’intero agosto a lavorarci sopra.
In settembre, dopo ripetuti rinvii, Maggi si rese irreperibile e compresi poi perché: stava per pubblicare La Costituzione italiana: diritti e doveri commentata da Antonio Di Pietro con prefazione di Francesco Cossiga. Presto avrebbe editato anche due testi di educazione civica sempre firmati dall’ex magistrato. Roberto Maggi cercò di convincermi che aveva grandi progetti e che non avrebbe avuto problemi a pubblicare anche me, perché era un liberale, e la cosa incredibile è che io credetti anche a questo. Continuai a lavorarci. Non ero cretino: ero di mente lineare, poco incline al barocchismo e al retroscena, figlio di mezzi tedeschi, soprattutto crederci era gratis.
Il mio ultimo appuntamento alla Larus di Bergamo fu il 3 febbraio 1995. Attesi due ore in una saletta e poi eccomi nell’ufficio di Maggi, dove appesa al muro c’era una gigantografia di Antonio Di Pietro firmata da Bob Krieger. Mi spiegò che non poteva permettersi di pubblicare il mio lavoro perché l’aveva mostrato all’ex magistrato. In sostanza aveva cercato di farsi bello con lui bloccando il mio libretto. Questo disse, almeno. Rimasi malissimo.
I primi di giugno 1995 ero a Monza a giocare a pallacanestro. Non possedevo un telefono cellulare e sul bordo del campetto d’un tratto comparve mio padre: mi disse che mi stavano cercando urgentemente dal «Giornale», quotidiano che intanto lui era passato a leggere. Finii la partita e solo molto più tardi, da una cabina del telefono, appresi che Di Pietro era stato inquisito a Brescia, e mi proposero di scrivere un articolo tipo «io l’avevo detto» sulla base di quanto avevo già scritto nel libro-intervista a Pillitteri. Dovetti precipitarmi al «Giornale» con la canottiera ancora madida di sudore e ricordo l’orrore negli occhi di Vittorio Feltri che allora se la tirava con l’eleganza british-campagnola. Scrissi un affresco sul reticolo di amicizie discutibili dell’eroe nazionale.
Il giorno dopo, più di un quotidiano fu costretto a inseguirmi. «L’Unità», circa il libro intervista con Pillitteri, scrisse di «veleni», e «la Repubblica» che «il pamphlet rischia di diventare un best seller che pare già depositato agli atti dell’inchiesta di Brescia». Il best seller mi fruttò in tutto 1.081.623 lire.
Cominciai a scrivere sul piccolo quotidiano «L’Opinione» grazie a una raccomandazione di Pillitteri, ma stavano per addensarsi nubi davvero nere.
Procure e redazioni, al tempo, erano invase da scritti anonimi contro la magistratura milanese, e si prospettava l’ombra di un Mister X che fungesse da suggeritore dei cosiddetti veleni indirizzati contro Di Pietro. Il clima da spy-story era a mille. Il 3 luglio 1995 sul «Giornale» lessi questo titolo: Mister X era già in un libro di due anni fa. Sottotitolo: Un memoriale anonimo pubblicizzò tutti i veleni e gli omissis del gruppo di Mani pulite. Testo: «Oggi andrebbe a ruba. Allora, nel maggio 1993, circolò per il tribunale come i samizdat clandestini del dissenso russo. Gli omissis di Mani pulite, un pamphlet di 192 pagine, raccontava già tutto. Gli anonimi e i Mister X che sono venuti dopo avevano alle spalle quel superdossier».
Avevo la certezza che non sarebbe finita lì. Ebbi l’irrazionale sensazione che qualcuno mi stesse cercando.
Non mi trovò la Spectre, ma Stefano Zurlo del «Giornale». Mi telefonò e mi chiese esplicitamente se Mister X fossi io. Negai. Per giorni. A un mio generalizzato timore si accompagnava la consapevolezza che la storia dell’inglese che scippa i libri dei giovani cronisti era incredibile, nel senso di poco credibile.
Cedetti, ovviamente. La verità per la verità interessava relativamente, lo sapevo bene: la scoperta di un ingenuo Mister X probabilmente avrebbe potuto smentire chi prefigurava dei potenti burattinai di centrodestra dietro la diffusione dei dossier anonimi. Decisi di correre il rischio. Al «Giornale» incontrai Maurizio Belpietro per la quinta volta in una quinta veste diversa: prima ero stato un imberbe che cercava lavoro, poi l’autore di un libro intervista con Pillitteri, poi l’autore di un libro inesistente su casi di malagiustizia, poi un giocatore di basket avvolto da un alone non propriamente di mistero, ora un Mister X di ventotto anni che viveva al quartiere Giambellino. Gli chiesi come avessero fatto ad arrivare a me e mi rispose che mi aveva riconosciuto dalla foto di bambino stampata dietro il dossier.
«Il Giornale», il 24 luglio, aprì la prima pagina con uno spaventoso titolone: Ecco l’autore del dossier Di Pietro. Sottotitolo: Filippo Facci, un giovane cronista dell’«Avanti!», scrisse due anni fa un rapporto in cui anticipava le accuse all’eroe di Mani pulite. Si insisteva ancora col «samizdat clandestino del dissenso russo». Stavo per finire in un mare di guai.
La Procura di Brescia mi convocò e mi interrogò per sei ore: il samizdat russo finì agli atti. Anche il libro intervista con Pillitteri era già finito agli atti. Vi finì anche la faccenda del libro sui casi di malagiustizia fermato dalla Larus. Mi chiesero del presunto editore inglese o irlandese e risposi che mi si era presentato come «Olinco» oforse «Holinko», non avevo mai visto il suo nome per iscritto. Gli inquirenti, com’era prevedibile, mi chiesero se avessi mai ricevuto altri dossier anonimi e gli consegnai quelli che avevo. Vollero sapere se li avessi utilizzati per scrivere il mio libro e li invitai a verificare che in qualche caso li avevo addirittura smentiti. Il giorno dopo, sul «Giornale»: Caso Di Pietro, cronista sotto torchio. Sottotitolo: Sei ore e mezzo senza neanche una pausa caffè.
Pochi giorni dopo trovai la casa perquisita e devastata da chi cercava chissà che cosa. Non mancava nulla, a parte qualche documento poco significante. Sporsi denuncia alla polizia e fui interrogato di nuovo a Brescia.
Settembre coincise con propositi di rinnovata normalità: scrivevo sempre per «L’Opinione», mi concentravo sul lato oscuro di Antonio Di Pietro e setacciavo nuovi casi di malagiustizia. Ogni tanto, almeno una volta alla settimana, sentivo Craxi al telefono. Mi chiamava lui. Gli piaceva che io venissi praticamente dal nulla, per quanto poteva saperne.
Il 12 settembre 1995 sulla «Repubblica» uscì un articolone titolato Il Mistero Holinko. Sottotitolo: Salamone indaga su un libro contro Mani pulite. Un estratto:
Chi è il signor Anthony Holinko? E chi si nasconde dietro la Marshall Ltd, casa editrice fantasma con sede forse a Dublino? La Digos bresciana sta indagando sul misterioso emissario dell’ancor più misteriosa Marshall, la casa editrice che nel ’93 pubblicò il libro Gli omissis di Mani pulite, un pamphlet che in Italia circolò semiclandestino, spesso in fotocopie, e che anticipava alcuni dei temi recenti delle accuse contro Di Pietro. Il pm Salamone sta cercando di capire se esistono dei legami tra la casa editrice irlandese e un’altra entità oscura apparsa sullo scenario recente di Mani pulite, l’agenzia investigativa americana ma con ufficio di corrispondenza a Parigi che avrebbe svolto, per conto di chissà chi, lunghe indagini sul passato dello scopritore di Tangentopoli.
Brescia. Dublino. L’America. Parigi. Il Giambellino.
Un mattino mi contattò l’ex mezzobusto del Tg2 Alda D’Eusanio, mai conosciuta prima. Disse che aveva letto le mie disavventure e mi elencò dei colleghi che le avevano parlato bene di me, tutti nomi però a me sconosciuti. La incontrai a Roma e mi spiegò che per il programma «L’Italia in diretta», su Raidue, avrei potuto fare dei servizi su casi di malagiustizia purché non trattassero di politici. Accettai e iniziai la trafila per il contratto. Pensai che potessero c’entrare Pillitteri o Craxi.
Il 14 settembre ero ancora a Monza a giocare a pallacanestro. Trillò il cellulare che mi ero finalmente procurato: era Craxi. Cercai di capire se c’entrasse con la faccenda di Raidue: «La conduttrice mi ha parlato di come si potrebbe trattare il tema del garantismo», gli dissi, omettendo nomi e cognomi come era d’uso. Ma non riuscii a capire.
La conclusione della telefonata, testuale, fu la seguente:
Craxi: A te ti controlleranno il telefono, devo supporre…
Facci: Sì, forse, ma non è un problema…
Craxi (scherzoso): Nessunissimo problema, neanch’io nessunissimo problema…
In realtà c’era problema. Aspettando la Rai, mi ributtai sull’«Opinione » e su Di Pietro, tema che tirava molto. Furoreggiava l’inchiesta su Affittopoli e io mi ero fissato di trovare i dati sull’appartamento a equo canone che il Fondo pensioni Cariplo aveva concesso all’ex magistrato alla fine degli anni Ottanta. Ne avevo già scritto nel mio libro fantasma e nel mio libro intervista a Pillitteri, con tanto di indirizzo, ma la notizia non era mai deflagrata. Mi procurai lo schedario del Fondo pensioni Cariplo e un funzionario mi diede tutte le conferme del caso. Mi capitò di parlarne al telefono col mio amico Luca Josi. Sinché un mattino, per coincidenze varie, capii che «il Giornale» avrebbe probabilmente sparato la notizia l’indomani e mi prese il panico. Allertai il direttore dell’«Opinione», Arturo Diaconale, e scrissi l’articolo in un battibaleno. Nel tentativo di anticipare «il Giornale» telefonai a tutte le agenzie di stampa perché preannunciassero quel che «L’Opinione» avrebbe pubblicato, ma servì a poco. «Il Giornale» l’indomani sparò la notizia in prima pagina e quasi nessuno si accorse che sull’«Opinione» ne avevo scritto anch’io. Era il 22 settembre.
Il pandemonio fu il 29 settembre. Il pubblico ministero Paolo Ielo, al Tribunale di Milano, denunciò «campagne giornalistiche coordinate da Hammamet» e citò espressamente gli articoli che «il Giornale» aveva dedicato all’equo canone di Di Pietro: disse che la diffusione della notizia era stata pilotata da Craxi a Vittorio Feltri, e la riprova, aggiunse, ne era un’intercettazione telefonica tra Craxi e Luca Josi, il mio amico. Feltri venne additato come un robot craxiano e i telegiornali di mezzogiorno si scatenarono. Io ci misi poco a capire com’era andata davvero: io avevo parlato a Josi dell’articolo che stavo preparando per «L’Opinione» e lui probabilmente ne aveva fatto cenno a Craxi, ma le varie telefonate erano state intercettate e i magistrati avevano capito che si parlasse di un articolo per «il Giornale» anziché per «L’Opinione». Passai una mezz’ora disperata: che fare? Esporsi di nuovo? Temevo per il mio contratto con la Rai.
Mi esposi, chiaro. Telefonai al «Giornale» e feci pure fatica a farmi ascoltare. Il giorno dopo, morale, ecco un’altra intervista dove spiegavo tutta la dinamica. Vittorio Feltri titolò il suo editoriale Esigiamo pubbliche scuse e però scrisse così: «Filippo Facci, e non un mio redattore, ha attinto notizie da fonte socialista riguardo a Di Pietro … “L’Opinione” ha pubblicato la notizia in questione proprio su segnalazione di Luca Josi. Facci, che è persona onesta, ammette tutto ciò in un’intervista che riportiamo». Ma come? Era il contrario della verità: io nell’intervista non dicevo niente del genere, non avevo attinto a nessuna fonte socialista, avevo solo parlato a Josi di un articolo che stavo preparando. Ma niente da fare, Feltri ripeté le stesse cose al «Messaggero» e alla «Repubblica». In un’intervista al «Corriere della Sera» giunse a dire: «Avevo ragione. Abbiamo rintracciato Filippo Facci il quale ci ha confermato quel che sospettavamo». Cioè: adesso erano stati loro ad aver capito, e ad aver rintracciato me, ricettore di notizie provenienti da Hammamet.
Il robot craxiano ero diventato io. Telefonai al «Giornale» e l’indomani fu abbozzata una rettifica dallo stesso Feltri, ma era tardi: un altro delirante articolo di un cronista giudiziario, sempre e incredibilmente sul «Giornale» dello stesso giorno, mi citava tra gli «irriducibili collaboratori di Craxi» e cercava di dimostrare chissà che cosa con un collage di intercettazioni varie. Intanto «la Repubblica» titolava Craxi, il burattinaio e il «Corriere della Sera» È Craxi il segretario di Forza Italia. Tutti i giornali pubblicarono centinaia di intercettazioni tra Craxi e il resto del mondo. Altri telefonisti craxiani erano Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi, e giornalisti come Enrico Mentana, Emilio Fede e Bruno Vespa. Un altro telefonista, Alessandro Caprettini, direttore dell’«Italia settimanale», fu licenziato. Il mio ex compagno di scrivania all’«Avanti!» Luca Mantovani, portavoce del parlamentare di Forza Italia Vittorio Dotti, fu licenziato a sua volta perché aveva spedito a Craxi la copia di un’interrogazione parlamentare. Mancavo io.
Tra i telefonisti c’era anche Alda D’Eusanio, l’ex mezzobusto che mi aveva proposto il lavoro alla Rai. I giornali pubblicarono un’intercettazione dove lei diceva a Craxi «Sarò la tua voce» e l’associarono a un’altra intercettazione, questa:
Craxi: A te ti controlleranno il telefono, devo supporre…
Facci: Sì, forse, ma non è un problema…
Craxi (scherzoso): Nessunissimo problema, neanch’io nessunissimo problema…
C’era problema. «L’Unità» del 5 ottobre deprecava il mio «contratto milionario» (66 milioni di lire lordi per un anno) e tre interpellanze parlamentari fecero il resto. Il contratto venne stracciato con il consenso del presidente della Rai Letizia Moratti. In sintesi: avevo dato una notizia vera, l’equo canone goduto da Di Pietro, e avevo perso il lavoro.
Nel giorno in cui «l’Unità» sanciva la fine di ogni mia velleità contrattuale, oltretutto, «Panorama» mi ritirava in ballo per il libro fantasma: un lungo e complicato articolo citava un dossier anonimo che avevo consegnato alla Procura di Brescia, uno dei tanti, e lo definiva «in stile Fbi». Si ritirava in ballo il samizdat russo o irlandese scritto al Giambellino. Il quotidiano «L’Indipendente» titolò Di Pietro spiato dai servizi segreti, citandomi.
Avevo ventott’anni, volevo fare il giornalista.
Nel periodo successivo divenni una specie di pendolare tra Milano e Brescia, nella duplice veste di cronista e di testimone. Di Pietro ormai era nel mio destino. Un’altra mia inchiesta sull’«Opinione», dopo una testimonianza che rilasciai sempre a Brescia, fece aprire un filone d’indagine contro l’ex magistrato per alcune sue presunte concussioni al ministero della Giustizia. Senza farla troppo lunga: mi sarebbe capitato di far iscrivere Di Pietro nel registro degli indagati altre due volte.
Di Pietro mi seppellì di querele e mi denunciò anche per calunnia. In una memoria difensiva chiese di appurare i miei rapporti con Craxi e di inoltrare rogatorie internazionali in Irlanda. Quando si discusse il rinvio a giudizio per calunnia, pochi mesi dopo, l’udienza preliminare durò sei ore e io e Di Pietro sfiorammo lo scontro fisico. L’ex magistrato ce l’aveva in particolare col mio libro fantasma: «È da quel dossier» disse «che sono cominciati tutti i miei guai». Ma quel dossier, che diversamente da altri non era un dossier ma solo un disperato e tentato libro, diceva tutte cose vere. Cose che reggono, ancor oggi, la prova del tempo. Fui prosciolto.
L’aria cambiò lentamente, ma cambiò.
Le storie di malagiustizia che riuscivo a trovare, grazie al rinnovato garantismo berlusconiano e al mio buon rapporto con Maurizio Belpietro, ottennero spazio sul «Giornale». Presi a collaborare anche con «Il Foglio» di Giuliano Ferrara. Ogni tanto, per esempio su «Panorama», uscivano articoli imbarazzanti che mi esaltavano come «il cronista che sapeva troppo ». Un quotidiano di Trento, non trovandomi, e in mancanza d’altro, intervistò mio padre. Dopo vari tentativi nel 1996 riuscii a trovare un editore anche per il libro sui casi di malagiustizia, intitolato Presunti colpevoli: lo pubblicò Mondadori. Altri giornali si soffermarono sul mio caso e a dirla giusta fu «Il Foglio»: «Dopo tre anni di peregrinazioni, Filippo Facci ha trovato l’editore, ma più probabilmente le condizioni politiche». Era la verità. Le stesse condizioni politiche, un anno dopo, mi permisero di pubblicare una prima biografia su Antonio Di Pietro sempre per Mondadori. Temendo chissà che cosa, Di Pietro disse alla «Repubblica»:
«So cosa vogliono fare, … chi lo fa. E ho preso le mie contromisure. Anzi vorrei dare un consiglio: chi sta realizzando la diffusione di un pamphlet che mi riguarda, ci pensi due volte».
Il libro uscì lo stesso. In autunno, davanti al palazzo di giustizia milanese, per la stupida legge dei corsi e ricorsi, ci fu una manifestazione del centrodestra in cui il libro fu addirittura agitato da qualche manifestante, o questo almeno lessi.
I primi di giugno 1999 ero di nuovo a Monza a giocare a pallacanestro quando un mio compagno di squadra mi disse che alla sua fidanzata, studentessa alla Cattolica, avevano chiesto di me durante un esame. Impossibile, dissi.
Era vero. L’esame era Storia del giornalismo italiano e nel tomo intitolato appunto Storia del giornalismo italiano dalle origini ai giorni nostri, a pagina 366, c’era un capitoletto titolato «Le fonti e le disavventure delle notizie». Si parlava di «tre casi limite, espressione di tre diversi momenti della storia italiana: portano il nome di Zicari, Pecorelli e Facci».
Di Giorgio Zicari ricordavo che era talmente ben informato che l’accusarono di essere colluso coi servizi segreti, di Mino Pecorelli che ebbe la fama di ricattatore prima di essere preso a revolverate nel 1979. Il terzo ero io.
Curiosa e ambigua la vicenda di Filippo Facci, un giovane di 26 anni nel 1993, che rimane disoccupato quando l’«Avanti!» chiude il 31 dicembre 1992. Il quotidiano del Partito socialista, fondato il 25 dicembre 1896 da Leonida Bissolati, viene travolto dallo scandalo di Tangentopoli che distrugge la carriera politica di Bettino Craxi, costretto a fuggire in esilio nella sua villa di Hammamet, Tunisia. Facci è autore di un libro intervista al cognato di Craxi, Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano. S’intitola Io li conoscevo bene. Nel 1993, colleziona particolari e notizie su Antonio Di Pietro, ne escono centonovantadue pagine che documentano le amicizie pericolose del pubblico ministero più famoso d’Italia e simbolo del rinnovamento morale. Il dattiloscritto viene pagato 4 milioni da un oscuro personaggio, sedicente editore di una piccola casa editrice irlandese. Alcuni mesi dopo, pagine del libro iniziano a comparire sui quotidiani ma il volume ancora non è stampato. Circolerà in seguito clandestinamente. I contenuti entreranno nell’inchiesta giudiziaria su Di Pietro che si concluderà a Brescia nel marzo 1996 con il proscioglimento dell’ex magistrato.
In autunno ricevetti qualche invito residuo a presentare la biografia su Di Pietro, e uno mi colpì in particolare: era del Rotary Club Milano Giardini, accanto al palazzo della stampa dove c’era la redazione dell’«Avanti!». Il giornalista che mi aveva invitato era lo stesso che anni prima aveva impaginato quel Di Pietro, facci sognare che troneggiava sulla copertina di «tv Sorrisi e Canzoni». Fu lui a dirmelo. Quella sera, per farmi voler bene, dissi subito qualcosa che ripeto ancor oggi: «Negli anni di Mani pulite, la percentuale di italiani favorevoli ad Antonio Di Pietro ha oscillato tra il 90 e il 95 per cento. Se mi applaudite, ora, presumo che sia perché al tempo rientravate in quel residuo 5-10 per cento».
Nel maggio 2000, vagando per Milano in motorino, imboccai sparato via Giulio Uberti in netto contromano: un’auto blu dovette inchiodare e rischiò seriamente di mettermi sotto, la ruota anteriore del mio scooter si fermò a non più di un centimetro dal suo paraurti. Alzai il braccio per scusarmi. Mi avvicinai e vidi che alla guida c’era il pubblico ministero Paolo Ielo, autore peraltro di un paio di querele contro di me. Sembrava impietrito. Abbassò il finestrino e mi disse: «Facci, ma se poi ti mettevo sotto, chi ci credeva che era colpa tua?».
Antonio Di Pietro, per molti anni, rifiutò ogni invito in programmi televisivi dove fosse prevista la mia presenza. Ha cambiato atteggiamento dal 2005 in poi.
Dei colleghi che uscivano dalla sala stampa quando vi entravo io, ora, almeno quattro sono discreti amici. Il collega che mi accusò d’aver pubblicato dei verbali falsi è passato a scrivere gialli metropolitani, come in fondo faceva già allora. L’altro collega che m’accusò di aver favorito la fuga di un dirigente socialista ha sposato una mia amica.
Nel tardo agosto 2009, con il ritorno di Vittorio Feltri in via Negri, ho abbandonato «il Giornale» dopo quindici anni. Il collega che fece un collage di intercettazioni telefoniche sul «Giornale» e fece strappare il mio contratto, Gianluigi Nuzzi, oggi condivide il mio stesso incarico – inviato speciale a «Libero» – sotto il mio stesso direttore, Maurizio Belpietro.
Dal 1992 a oggi è passata una mezza generazione e ci sono giovani e meno giovani che di Antonio Di Pietro sanno a malapena che faceva il magistrato. Credo di aver scritto questo libro anche per loro.
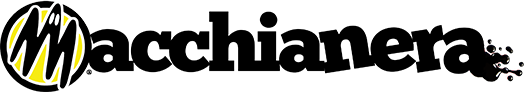
13 Trackbacks / Pingbacks
I commenti sono bloccati.