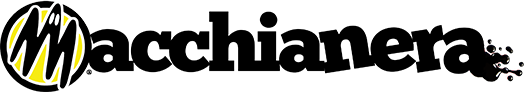Neppure io sono tanto sicuro di essere ancora vivo.
Mi sono raccontato che l’umanità si dividesse tra chi rimaneva intrappolato nel proprio temperamento e chi invece era dotato degli strumenti naturali per forgiarsi, variare dallo stampino originario, come se alcuni fossero un sottoprodotto genetico-ambientale e altri invece avessero più responsabilità circa quello che potevano essere e diventare.
Come se alcuni il coraggio potesselo darselo e altri meno.
Per i primi, mi dicevo, c’è un tempo in cui tutto è possibile; potremmo pateticamente chiamarlo soffio vitale, ma la scienza ha cercato di rovinare anche questo: ha spiegato che c’è un’età in cui la ghiandola pituitaria secerne in sovrabbondanza proprio quegli ormoni che mascherano le emozioni più sottili, come la paura.
Ecco che cos’era quella mia perfetta mancanza di paura: le scalate in solitaria, quella volta che da un rifugio sulle Dolomiti m’intimarono di rientrare perché altrimenti sarei morto assiderato, ma io no, bivaccai all’aperto e piuttosto feci ginnastica tutta la notte per scaldarmi, per restare vivo, io che mi credevo vivo, e invece era la ghiandola pituitaria.
I corsi di paracadutismo, le follie del bungee-jumping da ponti sempre più alti, la volta che dovetti rinunciare all’ascesa dell’Eiger perché vi arrivai sotto e scoprii che non ero capace, e tutto il resto, il troppo Nietzsche che mi sparavo a 16 anni e che mi risaliva ogni volta che passavo per esempio dal Faro della Guardia, nella più bella isoletta del Mediterraneo, scogli imperiosi che affioravano da un mare abissale sempre mosso, spumoso, quadri di Bocklin e di Friedrich tra loro frammisti, acque di tenebra e un vertiginoso desiderio del tuffo perfetto. Non è solo delirio di onnipotenza.
Come su quello strapiombo a Formentera, la gara a chi si tuffava dallo scoglio più alto senza sapere se il mare di sotto fosse abbastanza profondo: io e un mio sodale di cazzate partimmo da un’altezza di 8 metri, e quando più tardi stavamo per buttarci da 20 ecco che arrivò un bambinetto spagnolo che ci disse di aspettare perchè voleva controllare, sicchè scese sino al pelo dell’acqua e getto in mare una pietra che fece un rumoraccio. L’acqua era profonda non più di un metro. Mica ci fermammo, l’ultimo tuffo fu da 22 metri esatti: al mio amico, che si gettò per primo, esplose l’orologio, e quando riemerse mi mentì orrendamente: “Buttati, è una cazzata”. Mi buttai. La botta mi rintronò per tre giorni che passai disteso sulla sabbia, presi anche un’insolazione e poi la febbre.
Tutto il resto dell’isola intanto fornicava.
Il mio sodale non si dava pace perché l’orologio esploso gliel’aveva regalato una sua ex di cui era ancora innamorato, allora pur di ritrovarlo s’iscrisse a un corso di sub.
Io, per riflesso, presi tre brevetti da sub in tre anni.
I dive-master, gli insegnanti di sub, ogni volta si stupivano perché a me dei pesci non me ne fregava niente: m’interessava solo restare sospeso nel nulla, immobile, prediligevo le immersioni profonde sino 70-80 metri, dove puoi restare per pochissimo ma dove tutto è incolore, non c’è riferimento, sei nello spazio, nel rinfrancante brodo primordiale, nel protettivo liquido amniotico. Quelle parole di Nietzsche: “Si scende in mare, a poco a poco si perde il passo sicuro sul fondo, e alla fine ci si abbandona alla mercé dell’ondeggiante elemento… un movimento dell’anima che è affine al nuotare, al fluttuare”.
Nietzsche avrebbe voluto essere un animale marino, avrebbe voluto perdersi come capitò a me una tarda sera: era la mia prima immersione notturna, non c’era la luna, dal gommone non si vedeva neppure l’acqua e sembrava di galleggiare su un’astronave cabrio. A meno 22 metri mi si ruppe la torcia, e i due dive-master non si girarono a controllarmi e sparirono dietro uno scoglio che si chiamava Scoglio rosso, li persi, mi persero. Rimasi nel perfetto e buio nulla, non potevo capire dove fossero l’alto e il basso perché non vedevo le bolle dell’ossigeno che buttavo fuori, non potevo sapere quanto me ne rimaneva, e anche orientandomi non avrei potuto emergere perché nel buio non si può valutare la velocità di risalita, avrei rischiato di morire per sovradistensione polmonare. Rimasi lì, e fu perfetto, appigliato a una pianta marina che neppure vedevo, con pesci o alghe o demoni che mi sfioravano nel buio, ammiccavano.
Fu perfetto ma erroneo, perché implicava comunque una consapevolezza nella morte e della morte, quando invece solo i vivi hanno il problema della morte, e per smettere di porselo in fondo basta morire. Me ne consolo. Neppure il sonno senza sogni può restituirci l’idea della morte. L’unica volta che l’ho presunta è stata risvegliandomi da un’anestesia, la percezione fu davvero di provenire dal nulla, e non fu affatto spiacevole.
Quella notte, comunque, i dive-master mi ritrovarono dopo circa dieci minuti, e mi riportarono in superficie, costernati: mi riportarono definitivamente lassù, in mezzo agli uomini che a un certo punto smettono di essere vivi e anche per questo fanno figli, unici nel creato ad avere la percezione del tempo che passa, unici a non conoscere l’attimo che cancella l’attimo come accade nel sempre-presente degli animali, unici a vivere attimi che morendo lasciano un’ombra di sé, unici a vivere un tempo che rimane come in loro inscatolato, un tempo che sanno sparirà, persino il futuro sanno che sparirà.
E’ il loro specifico, percepiscono la fine della vita mentre questa ancora galoppa: è per questo che prendono appunti per il dopo, e si riproducono per istinto di conservazione in un universo che istinti di conservazione non ne ha.
I dive-master mi riportarono in superficie dove il mio sodale di cazzate che sognava il K2, intanto, aveva fatto due figli e costruito un paio di palazzine, mi riportarono là fuori dove sorprendersi diventa sempre più difficile, perché basta un’istante e una situazione finisce inquadrata tra il già vissuto e il già visto, e i navigati della vita rischiano di guardare ai sentimenti come un sessuologo rischia di guardare il sesso, come un architetto rischia di guardare una casa, aspettando e sperando che esista ancora il sempre nuovo, sinchè non ci credi più: ed ecco la fine, la fine del patetico soffio vitale, o forse l’esaurimento della minchia di ghiandola pituitaria, qualcosa per cui insomma cominci a presumere che sia ripetitivo ciò che è irripetibile e cominci a giudicare dalle apparenze perchè pensi che tanto, ormai, ci prendi sempre.
Vorrei che esistesse l’inferno solo per sbatterci dentro tutti i cristiani e gli ebrei e gli hegel e i marx che hanno reso teleologica questa mia civiltà, l’hanno inzuppata di finalismo, ci hanno propinato un assoluto che è come l’uovo nella maionese a contatto con l’olio.
Il dio cattivo dei cattolici l’avevo abbracciato quando da bambino era morta mia madre, ma l’avevo presto abbandonato prendendolo come un’offesa all’intelligenza, pura sociologia. A 12 anni lessi un razionalista inglese: “Le religioni di oggi sono tutte false a dannose”. Aveva ragione.
Già a 14 anni mi fu semplice liberarmi di un dio che per migliaia di anni aveva lasciato sussistere dubbi prospettando poi le conseguenze più terribili nel caso di trasgressione della verità, un dio che pur teoricamente possedendo questa verità se ne stava a guardarmi mentre mi tormentavo penosamente per raggiungerla.
Ho passato la prima giovinezza a cercar di diventar me stesso, a non diventar meramente schiavo della mia biografia, ma è uno sforzo immane e debilitante, perché l’indipendenza morale è una dimensione che non ti viene perdonata, mai. Tutto il resto era politichetta, pedagogia sociale, comunione senza liberazione, non lotta delle opinioni, ma lotta tra fedi nelle opinioni.
Le prime consapevolezze di non essere immortale le ebbi a cavallo tra il 2000 e il 2001, quando avevo 33 anni. Non ero praticamente mai stato da un medico in vita mia, ma una strana pulsione mi spinse a visitarne uno che tanto era gratis. Mi guardò un neo sulla schiena che si rivelò essere un melanoma che avrebbe potuto uccidermi in breve tempo, sicchè fui operato d’urgenza a prezzo di una cicatrice che oggi mi piace molto. Qualcosa comincià a sedimentarsi.
Un dermatologo piuttosto esplicito, poi, negli stessi giorni, mi guardò un foruncolo che avevo sul naso e mi disse che poteva essere un classico sintomo di sieropositività: allora, appena operato, feci pure l’esame dell’Hiv e aspettandone l’esito mi esercitai per quindici giorni all’idea del tramonto inesorabile, ma in realtà stavo giocando ancora.
La domenica successiva, giocando a pallone, incorsi nel primo infortunio sportivo nella mia carriera; da principio non me ne accorsi, avevo giocato a basket per tutta la vita senza mai neppure una storta, mi chiamavano l’uomo di gomma sicchè la domenica dopo provai a rigiocare, ma fu penoso. Fui costretto a tornare da un ortopedico (ex dell’Inter: ero masochista) per scoprire che mi ero rotto un legamento: e allora cure, ultrasuoni, elettrostimolazioni, stampelle, uno strazio per quasi un anno. Il complotto contro di me si stava facendo incalzante, anche perché Bettino Craxi morì di lì a poco e fu un dolore terribile che mai avrei pensato potesse coincidere con la fine della prima parte della mia esistenza, quella da persona viva.
Ero stato a trovarlo poco tempo prima, l’avevo visto zoppicare sino alla piscina e buttarsi di testa, scherzavamo, era vivo. Stetti male come ci sto male ancora oggi, e con le poche persone a cui volevo bene fu molto difficile giustificare un lutto privato per un personaggio pubblico. Non capirono, e, soprattutto – ma qui anestetizzo i racconti, perché sono privati – non mi comprese una femmina che frequentavo per quanto paresse geneticamente strutturata per farmi soffrire, classica storia che si dipanava tra lacerazioni atroci nel mio tentativo superomistico di mantenerla in vita, mentre lei pareva costruita in laboratorio per cavarmi dall’inconscio tutta la porcheria che vi avevo sedimentato. Il figlio, alla fine, lo fece con un altro. Tutto versava contro di me.
Mio padre nello stesso periodo fu ricoverato più volte per problemi vari, e dovetti incredibilmente prendere atto che era mortale persino lui. Poi avrei bisogno di pagine intere per cercar di descrivere che cosa mi trafisse nei successivi e solitari pellegrinaggi musicali a Parigi, Venezia, Vienna e San Pietroburgo, sino ai dieci infiniti giorni passati a Bayreuth, nel tempio wagneriano.
Non menerò il torrone con Wagner, ma quando dal golfo mistico riecheggiò la musica più cupa e impressionante che forse abbiano mai scritto, mentre il crepuscolo si faceva notte, io ero lì, alla fila 21 posto 21, e guardavo la gente di Bayreuth paralizzata di una commozione torbida, stregata, voluttuosa, inebriata e velata dalla mestizia del tempo che se ne andava. Intravedevo lacrime su volti raggrinziti e vecchi signori con la testa tra le mani, e capivo che stavo diventando uno di loro. Non ero più tanto sicuro di essere ancora vivo.
Terminai l’estate nella mia solita isoletta del mediterraneo, volevo smaltire la sbornia wagneriana e confrontarmi col silenzio imperfetto della vita vera, col mare, la luce, l’acqua come unica dimensione naturale pienamente penetrabile. Un’isola dove non ci fosse nessun luogo in cui seriamente dovessi andare, e nessuna tappa da bruciare, nessun futuro e progetto da inseguire, nessun prologo da perpetuamente organizzare.
Cercavo il volto della vita autentica che dilata le giornate all’inverosimile, un presente che bastasse a se stesso e si facesse lento, pieno, assoluto, senza più occupazione, sfuggente soddisfazione. Ma tutto seguitava a versare contro di me. Sull’isola avevo raggiunto una femmina con cui, a Milano, avevo intrapreso una storia breve, intensa e disordinata. Io ero intriso del momento che stavo vivendo, e allora litigammo, uscii in barchino da solo, la maltrattai al punto che lei decise partire “col cuore spezzato”, come mi confidò una persona a lei cara. Lei prese l’aliscafo e andò a Fiumicino. Prese un aereo e andò direttamente in Israele. Dopo l’11 settembre si spostò in Afghanistan. Il 21 novembre spararono a lei e ad altri tre reporter.
Dio è dove lo trovi, e i miei appunti per il dopo, in realtà, seguito a tenerli per me, preferirei farmi incatramare e impiumare piuttosto che svelare davvero i miei panteismi privati. A me era sempre bastata la natura e soprattutto la musica, la musica vera: non l’abbruttimento con musiche ossessive e frastornanti, gli sguardi protesi alla ricerca di raduni primitivi e stordenti che spoglino le genti delle singole personalità che non hanno la forza di avere.
Religione e Tecnica sono colpevoli di una paura della morte che nessun’altra epoca ha conosciuto così forte: entrambe ci hanno allontanato dalla morte come precondizione della vita, entrambe ce ne hanno requisito la proprietà per attribuirla a un dio o per rinchiuderla in stabilimenti per morire. Non mi pare di aver paura.
La morte delle persone care è certo il principio di un’amputazione, ma è così pure un riavvicinamento alla simbiosi perfetta, al tutto, a ciò che era preesistente alla separazione della nascita. Io avevo la musica, che resta la più prossima riformulazione dell’esperienza percettiva arcaica del corpo materno, un bagno di suoni primordiali della vita endouterina, la realizzazione allucinatoria del desiderio di un Eden un cui non vi sia distanza tra parole e cose. Nel canto gregoriano, come nel mantra, si può ritrovare una consonanza con la musicalità religiosa dell’uomo primitivo che divinizzava gli eventi legati alle leggi cosmiche: il culto del Sole, della fertilità, del corpo della donna e quindi della Dea Madre. La musica è passaggio dal mondo acustico a quello della luce, simulazione di una nuova nascita in cui tutto ciò che era prima è più fondamentale di ciò che sarà dopo. La musica è un’esperienza da associarsi a situazioni primitive e fusionali di cui è residuo, rievocazione, nostalgia. Della verità, una verità inafferrabile e celata nel transitorio, la musica non è che un travestimento, una rievocazione tesa a un paradiso originario e senza tempo. La musica sorge palesemente dalla lotta tra le forze antagoniste dell’universo – la vita e la morte – ma non rappresenta nè l’una nè l’altra: esprime una perenne tensione fra opposti.
Religione e tecnica invece falsificano la morte, ti impediscono di presidiarla, di ascoltarla. Un bambino che ascolti musica da solo nella sua cameretta, oggi, lo accompagnano dallo psicologo.
La musica, come la verità, puoi tuttavia tentare di condividerla, ma non puoi parafrasarla o tradurla, non puoi separarla da un senso che non puoi conoscere: il suo privilegio consiste nel saper dire ciò che altrimenti non può essere detto. E’ lì, ti pervade, il suo linguaggio palese ne contiene uno occulto che sfugge costantemente, e però ti sfida a decifrarlo. La musica è la migliore formulazione possibile di un qualcosa a noi completamente sconosciuto. E’ una profondità nascosta alla superficie. Non ne ho paura. Muore cento volte chi ha paura della morte.
Venga pure a prendermi, non farò troppe storie.
Il Foglio, settembre 2007. Di prossima pubblicazione nel volume ‘Appunti per il dopo’.