Stasera non avrei scritto niente, se non che prima di coricarmi, passando davanti allo specchio, ho visto la faccia di uno che ha scampato le Diaz per pura botta di culo.
Siccome un pensiero tira l’altro, mi sono domandato che faccia avrei nel caso in cui. Un po’ più sbattuta di certo: magari un dente in meno (qualcuno effettivamente lasciò un dente sulle scale). Forse più calvo, chi lo sa, più rugoso e interessante. Io non voglio passare per un reduce – è ridicolo, Genova furono tre giorni – però capisco perfettamente la gente che va in guerra, la scampa e poi si sente in colpa per tutta la vita. È un senso di colpa strano, misto a una curiosa invidia, e alla voglia di contar balle ai ragazzini al bar.
Io alle Diaz in quel momento avrei voluto esserci. Nel senso che avevo una gran voglia di andarci, venti minuti prima che le Diaz passassero alla Storia. Suona buffo, ma era tutta una questione di blog. Volevo aggiornare il blog, che poi era un modo di avvertire una ventina di persone che l’avevano letto fino a poche ore prima che ero salvo e stavo bene. Era tutto puerile e terribilmente serio allo stesso tempo. Le scuole cablate erano due, una di fronte all’altra: la più grande aveva la Sala Stampa e i server, ma i computer giravano con un cacchio di sistema operativo alternativo che s’inchiodava continuamente. Nelle Diaz invece c’era il vecchio stramaledetto windows duemila. Io dunque, mentre facevo la fila alle Pertini per accedere al sospirato blogger.com, avevo una gran voglia di provare se lì di fronte non ci fosse meno coda. La Diaz, fino a quel momento, la conoscevano in pochi, tra cui io; io che due sere prima mi ero coricato proprio con le chiavi della Diaz in tasca, perché nel cosiddetto servizio d’ordine del Movimento dei Movimenti si faceva carriera rapidissimamente, bastava continuare a preoccuparsi mentre la gente andava a dormire.
Io dunque ero indeciso se restare lì o andare alle Diaz. Se ci fossi andato, chi lo sa? forse oggi passerei i miei pomeriggi a fissare il muro o a sfogliare i vecchi manga, magari soffrirei la depressione e peserei 120 chili; oppure mi sarei liberato di ogni borghese inibizione, come quelli che scampano un disastro aereo e non hanno più paura di nulla, e lavorerei sulle impalcature dei grattacieli, chi lo sa. Se invece fossi rimasto lì in fila alle Pertini, cinque minuti dopo i carabinieri mi avrebbero semplicemente convinto ad accucciarmi al muro con le mani alzate, mentre sequestravano i server con un sacco di immagini compromettenti (compromettenti per loro, visto che in tutti questi anni non risulta le abbiano usate per incriminare chicchessia). Ma non feci nulla di tutto questo, perché passò Glauco a dirmi che andavano a prendere una birra lì all’angolo e io dissi ma sì, chi se ne frega. Era tutto molto serio, e allo stesso tempo no.
Come Buzzati, quando la sera tornava a casa dal grande giornale e scriveva su un quadernetto il Deserto dei Tartari; come Fenoglio quando da bambino montava sui tetti e s’immaginava di sparare agli invasori, anch’io probabilmente nel mio piccolo pensavo che ci sarebbe stata una guerra prima o poi, almeno una Battaglia, e che solo la Battaglia mi avrebbe fatto uomo. La guerra però non arrivava mai e così ho provato ad arrangiarmi con Genova.
A Genova le cose erano estremamente serie, in effetti, e allo stesso tempo restare seri era spesso difficile: tutto rischiava di diventare puerile da un momento all’altro. La cosa di cui sono più fiero è il servizio d’ordine al concerto di Manu Chao, quelle quattro ore spese a sgolarsi per avvertire i ragazzini di non oltrepassare la linea rossa della corsia ambulanze, e per cortesia di non rompersi l’osso del collo sugli scogli. Mercoledì sera, prima di ritirarmi al campeggio, avevo lungamente cercato di mettere pace tra due skin francesi impasticcati che se le davano in piazzale Kennedy, e non avevano l’età di mio fratello. Poi mi ero scocciato: ero un adulto, mica Madre Teresa.
In seguito ci furono le cariche di venerdì, e bamboccioni se n’erano visti molti, in uniforme e in tenuta da movimento. Noi stessi, tipici modenesi, ondeggiavamo da una piazza tematica all’altra, cercando di mantenere un distacco critico, ma anche annusando a pieni polmoni la voglia di mettersi nei guai, il profumo con cui la troia Guerra seduce tutti i ragazzini. Poi era corsa voce di un morto, anzi di due, di tre; dalla città salivano fili di fumo e tutto sembrava allo stesso tempo serio e patetico, e per quanto non fossimo allegri eravamo più che mai contenti di essere lì piuttosto che altrove. Sabato ci eravamo svegliati con una rancorosa sensazione di trovarci nel giusto, e le cariche e la lunga anabasi per i quartieri della città scoscesa in fondo li avevamo vissuti con lo spirito più adatto: che era lo spirito d’avventura. All’ora in cui Glauco mi invitò a bere una birra tutto sembrava finito, la tensione era scesa di molto; e l’ansia di aggiornare il blog (l’unico blog a Genova!) poteva di nuovo sembrare una cosa puerile.
La birreria stava dietro l’angolo e faceva affari d’oro, perché era l’unica rimasta aperta in quel quadrante della città. C’incontrammo una ex compagna di classe di Glauco che si era trasferita in Belgio e faceva teatro e tornava in Italia solo per le rivoluzioni. Quella birra non l’ho mai bevuta – ci fu un frastuono di sirene, e quando uscimmo a vedere, restammo molto stupiti che non fossero i soliti CC o PS o GdF o Forestali, ma una colonna di ambulanze e Croce Rosse. Magari le aveva chiamate proprio Fournier, che ringrazio. Ho sempre pensato che fossero state molto tempestive, come se i picchiatori delle Diaz le avessero chiamate ancora prima di irrompere.
Voi, com’è giusto, la storia la conoscete dalla A alla Z: il poliziotto che si graffia il giubbotto con un coltello e poi lancia l’allarme (hanno cercato di accoltellarmi), i carabinieri e i poliziotti che entrano, le ambulanze che arrivano, le barelle che escono, il questore il giorno dopo in conferenza stampa che mostra le prove della resistenza armata della Diaz: un piccone fregato al cantiere di fianco, le molotov che poi qualche poliziotto confessò di avere fabbricato, e che in seguito sono misteriosamente scomparse, un sacco di coltellini svizzeri e pacchetti di kleenex da non sottovalutare (se si pensa che la principale fobia dei ragazzini in uniforme da poliziotto erano i fantomatici “palloncini di sangue infetto”). A raccontarlo sembra una comica, col sangue finto e i pugni per finta che fanno saltare i denti per finta.
Quando però le vivi, certe situazioni, ti trovi come nel mezzo della battaglia: non hai la minima idea di quello che sta succedendo. Dopo esserci nascosti per un quarto d’ora dietro la saracinesca della birreria, alla fine cedemmo alla tentazione di andare a vedere cosa succedeva. Non si capiva nulla, e non c’era nessuno che ti raccontasse la stessa cosa. Videocamere dappertutto: quella scena l’avete vista in tv in trenta soggettive diverse, e dappertutto c’è qualcosa di me: una spalla, un grido, un sandalo. Siccome nessuno mi aveva spiegato che i server avevano preso il volo, io mi fiondai subito all’ufficio stampa per aggiornare il blog, che ora di nuovo mi sembrava la cosa più adulta da fare; stavo inutilmente cliccando il tasto refresh quando sentii un boato d’umana indignazione che mi scaraventò di nuovo fuori, e mi fece arrampicare sulla cancellata di fronte alle Diaz. Cosa stava succedendo?
“Portano via un morto”.
Il morto in realtà era una barella carica delle famose munizioni di cui sopra, ma coperte da un telo verde impermeabile, che faceva un effetto body bag orribile a vedersi. Rimasi appeso alla cancellata per un tempo che mi sembrò interminabile, fregandomi del blog e probabilmente inveendo e fischiando a poliziotti e infermieri, ben sapendo che non era la cosa più adulta da fare.
Più tardi sono entrato, come altri cento, e ho visto le cose che avevano già visto altri cento: ma le ho viste male, in fretta, sicché quando le rifanno vedere in tv (molto di rado) non le riconosco, oppure confondo ricordi televisivi e reali, e mi vergogno. La sensazione di trovarsi al centro delle cose, che ci aveva aiutato a drizzare le antenne per tre giorni, stava già svanendo. Ricordo sempre quella porta dei bagni forata da un colpo secco di manganello: m’immagino sempre di trovarmi lì, di chiudermi in bagno, di sentire le botte di manganello e poi di vedere la mano del poliziotto che si sbuca dal foro, trova la maniglia e la apre. Ma non ero lì, per cui in fondo il mio è solo un film come un altro.
Genova mi ha fatto paura, bisogna dirlo: quando tornai a casa continuavo a sentire le sirene, di giorno, di notte, per una settimana. Poi mi è passata.
Genova mi ha dato la scossa, e per alcuni mesi mi ha spinto a fare cose serie; ma in mezzo alle cose serie continuavano a esserci molte storie buffe, ridicole e apparentemente inadeguate, che col tempo hanno preso il sopravvento. Ho concluso che la vita è così, seria e ridicola insieme, che il bambino egotico e curioso che uno si porta dentro non deve per forza morire in battaglia: può restarsene lì, a patto che non rompa troppo.
Adesso vivo in una città ancora più piccola, davvero una miniatura; continuo ad aggiornare il blog per un motivo o per un altro e non racconto balle da reduce ai ragazzini, perché un reduce non sono.
I ragazzini poi sono terribili, perché ogni anno ne arrivano di nuovi, e non c’è cura migliore alle nostalgie sciocche di una nuova infornata di allegri ignoranti. Questi che stamattina han fatto l’esame sono del Novantaquattro, cosa vuoi che gli freghi di un tafferuglio che scoppiò a 9 anni? Quello che gli fa drizzare le antenne sono gli argentini torturati sotto lo stadio e lanciati dagli aeroplani senza paracadute. Il desaparecido volante è un enigma che coinvolge Storia, Geografia e Scienze: da che altezza venivano lanciati? Che velocità raggiungevano durante la caduta? Cadevano in moto uniforme o con un’accelerazione costante? Morivano asfissiati, inceneriti come le meteore, o annegavano? Questi sono misteri intriganti per un ragazzino.
Io non vorrei dover aggiungere misteri alla Storia del dopoguerra, che già ne sovrabbonda. Crescendo, gli stessi ragazzini dovranno prendere appunti sull’Italicus, sulla Stazione di Bologna, su Ustica, Piazza Fontana… io vorrei che almeno si risparmiassero le Diaz. In fondo sono un mistero minore, che con un piccolo sforzo da parte dei carabinieri e dei poliziotti onesti si potrebbe archiviare in breve. Non era mica la guerra, anche se “Diaz” ha sempre avuto un suono sinistro (i giornalisti non avrebbero potuto inventarsi di meglio). Si disse subito che era l’Argentina, il Cile. No: erano le Diaz, nemmeno una scuola vera, una piccola palestra in cui le forze dell’ordine dello Stato repubblicano persero del tutto l’autocontrollo, e ancora aspettiamo che ci spieghino il perché.
Dovrebbero farlo. Sarebbe un bene per loro, per il Senso dello Stato dei nostri ragazzini, e anche per me. Personalmente non ho voglia di rivedermi tra cinque o dieci anni in un documentario sgranato, mentre mi appendo all’inferriata come un deficiente. Non vorrei perdere tempo a spiegare a un mio figlio perché ero lì. Ero lì perché in quel momento non avrei sopportato di essere altrove: fine.
(Scritto il 14/6/2007)
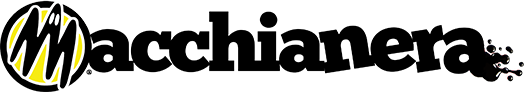
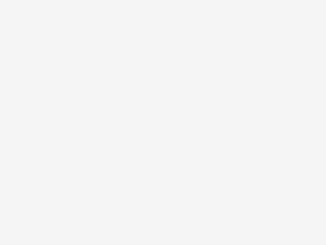
chapeau, ancora!
bellissimo! nulla da aggiungere e nulla da togliere
Già, ragazzini.
Consiglio “Elogio della guerra” di Massimo Fini. Illuminante e tremendamente in tema coi fatti del G8.